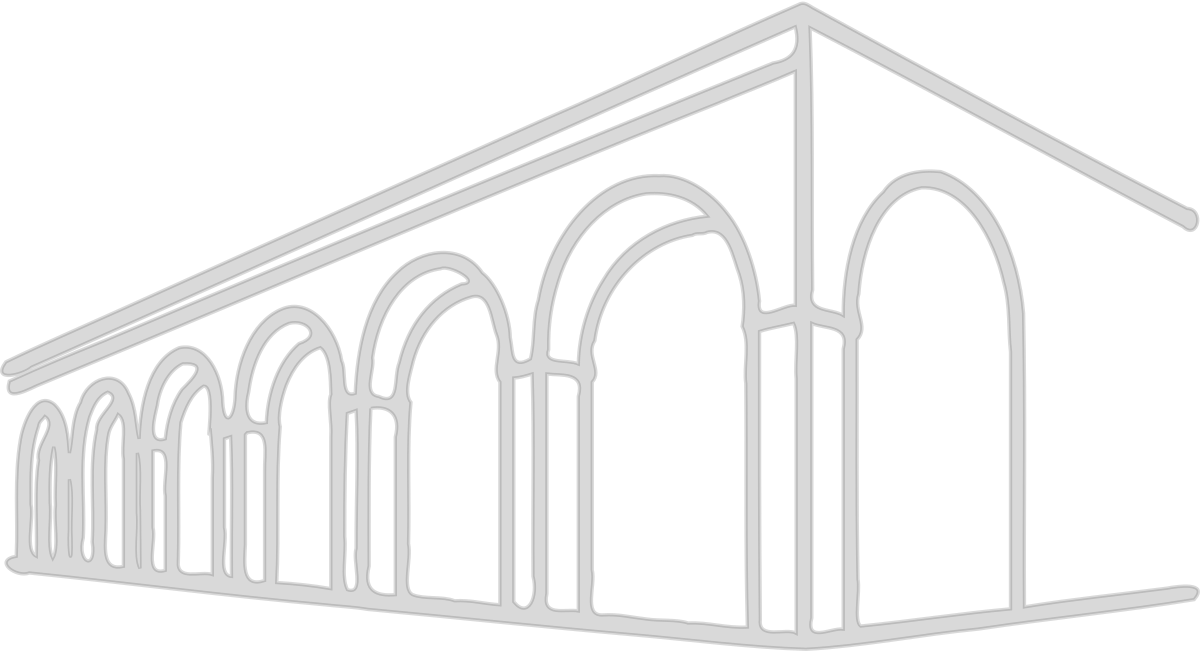Ieri a Carpi abbiamo assistito a un curioso paradosso temporale: mentre la città si prepara ad accogliere la memoria di Srebrenica attraverso i diari di un padre, i suoi cittadini si trovano a confrontarsi con questioni molto più prosaiche ma altrettanto urgenti del presente.
La rassegna "Balcanica" porta sul nostro territorio una riflessione necessaria sui fantasmi dell'Europa, quelli che continuano a infestare la nostra coscienza collettiva trent'anni dopo. Il documentario "I diari di mio padre", che verrà proiettato venerdì all'Auditorium Loria, ci ricorda che la memoria non è mai un esercizio retorico: è sempre un atto politico, un modo per comprendere il presente attraverso le lacerazioni del passato. Bekir Hasanović che scambia una moneta d'oro per una videocamera nel 1993 ci insegna che documentare la realtà, anche quella più atroce, è già un atto di resistenza.
Ma mentre Carpi si conferma attenta custode della memoria europea, il presente ci riserva sorprese di tutt'altro genere. La storia della CMB che stabilizza 156 lavoratori è una di quelle notizie che scaldano il cuore e confermano il DNA cooperativo della nostra città. In tempi di precarietà dilagante, vedere una cooperativa che sceglie di investire sulle persone piuttosto che sui profili di bilancio è quasi rivoluzionario. Via Carlo Marx non è solo un indirizzo: è un manifesto che ancora oggi trova la sua applicazione pratica.
Meno edificante, invece, la vicenda che emerge dalla polemica sui medici di famiglia e gli incentivi economici. L'idea di pagare i dottori per prescrivere meno ha qualcosa di grottesco che ricorda certi romanzi distopici: un euro e venti centesimi per assistito all'anno, il prezzo della parsimonia medica. Roberto Pieralli dello Snami ha ragione quando solleva dubbi deontologici: come può un paziente fidarsi completamente del proprio medico sapendo che ogni prescrizione in meno gli frutta qualche spicciolo? È il trionfo della burocrazia sanitaria che trasforma la cura in algoritmo e il rapporto medico-paziente in una partita a somma zero.
E mentre Carpi dibatte di medicina ed economia, dalla Bassa arriva l'eco di una crisi che tocca da vicino il nostro territorio. La situazione della Gambro-Vantive di Medolla con i suoi 500 lavoratori nell'incertezza è il simbolo di un capitalismo finanziario che compra e vende aziende come fossero figurine, dimenticando che dietro ogni stabilimento ci sono famiglie, competenze, storie. Il distretto biomedicale che ha reso famosa la nostra provincia nel mondo rischia di diventare vittima della sua stessa eccellenza, appetibile per i fondi d'investimento quanto fragile nelle loro mani.
C'è una sotterranea coerenza in queste storie apparentemente slegate. Tutte parlano di responsabilità: quella della memoria verso le generazioni future, quella dell'impresa cooperativa verso i lavoratori, quella dei medici verso i pazienti, quella delle istituzioni verso il territorio produttivo. In un'epoca in cui la responsabilità sembra essere diventata un concetto vintage, Carpi dimostra di saper ancora distinguere tra ciò che è giusto e ciò che è semplicemente conveniente.
La città che domani sera si raccoglierà all'Auditorium Loria per ascoltare la storia di Srebrenica è la stessa che sa ancora indignarsi per la mercificazione della salute e celebrare chi sceglie la stabilità del lavoro contro la precarietà del profitto. Una Carpi che non dimentica e non si arrende, fedele a quella tradizione di solidarietà che l'ha sempre contraddistinta, dai tempi di don Zeno Saltini fino ad oggi.